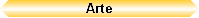|
Il respiro di Anselmo - Sculture 1948-1965
Di Flavio Arensi
"[…] I’ mi son un che, quando
Amor mi spira, noto, e a quel modo
ch’e’ ditta dentro vo significando".
Dante Alighieri, Purgatorio XXIV 52-54
Guardando oggi la scultura di Anselmo Francescani (1921–2004), anzi tastandola ad occhi serrati per raggiungerne il senso profondo della presenza, sembra di ascoltare tangibilmente il fiato sottile di un respiro, ed insieme cogliere i mutamenti del petto che di sospiro in sospiro continua a palpitare. Questo ansimo è talvolta leggero, altre penetra fin dentro al cuore col movimento peristaltico, esplodendo poi ritraendosi come un mantice. Qui l’autore significa il suo trovarsi al centro ed insieme ai bordi del mondo, nell’alveo stesso dei big bang: uso il plurale perché mi sembra limitativo insistere sull’esistenza di un solo grande scoppio, quando tutto muore e rinasce infinite volte, e così anche il cosmo detona, si allarga, restringe, implode. Pur nella necessità di mutare il soggetto e la foggia, egli mantiene coerente l’afflato che vivifica tutte le sue creature, dalle prime esperienze fino all’abbandono della scultura, avvenuto nel 1965, per insegue il delirio di un’opera pittorica unica e magniloquente, costruita a più riprese nel dettato incalzante del ciclo dedicato al martirio del popolo armeno: una volontaria mutilazione che partecipa della follia catastrofica cui è sottoposto il popolo armeno, una rinuncia alla scultura che vale come compartecipazione emotiva di quella tragedia vasta e totalizzante. Come un fiume carsico, tuttavia, l’esigenza di fare scultura riaffiora nel 1988, nella ricca stagione che porta a compimento gli studi e le visioni abbandonate due decenni prima (cui sarà dedicato in futuro un saggio a parte).
L’opera scultorea di Anselmo risente inizialmente del magistero di Marino Marini (1901-1980), incontrato nelle aule braidensi al termine del conflitto bellico, dopo aver già conseguito la licenza in pittura con Aldo Carpi (1886 - 1973). Le prime forme sono alla ricerca della monumentalità spuria, troncata dall’anelito di una completezza serena, stridente con la presa di coscienza postbellica. Si tratta di esercizi scultorei che servono a raggiungere una buona connotazione tecnica. Accade però molto presto il distacco dagli approdi accademici, e l’agguanto di un’immagine alternativa - a cominciare dal nuovo decennio degli anni Cinquanta - legata ad una tensione drammatica eppure mai esasperante, un blocco delle forme che agonizza le figure, tagliandole in angoli strutturali di ritmo sincopato, comunque di una musicalità ragguardevole e cadenzata, d’altronde precipua di tutta la produzione scultorea e grafica del periodo. Il passaggio principale avviene con la rielaborazione di tematiche ormai endemiche al circuito artistico italiano, le maternità o più ampiamente la figura femminile, quale metafora riequilibrante degli sconvolgimenti interiori condotti nel Ventennio; ci sono casi come Arturo Martini (1889-1947) che dettano il clichè, oppure la genialità di Marini, ma anche gli esempi drammatici di Alfredo Chighine (1914-1974), impegnato nella sbozzatura di statue dal carattere espressionista, vicine alle forme in legno di Giovanni Paganin (1913-1997) e alle derivazioni tedesche o nordiche di un’arte lontana da Milano. Inoltre, si aggiunga la vicinanza di Karl Plattner (1919-1986) e Leonardo Cremonini (1925), con cui costruisce un linguaggio comune di notevole innovazione, bilanciato su carichi d’esistenza e tagli prospettici, nel suo caso resi tridimensionalmente. L’anelito di Corrente e del Realismo sociale di stampo politico qui non sembra mantenere alcuna prospettiva, di certo non vi è la dolorosa constatazione intimista di alcuni autori più giovani, quelli dell’ormai noto Realismo esistenziale deflagrato nel 1954, né si accetta un rapporto dialogico con le tendenze informali ed astratte, oppure succube delle grandi stagioni parigine, in primis quel Picassismo che opprime buona parte della gioventù artistica coeva. Anselmo, come spesso accade, non può che recuperare un proprio spazio di lettura critica della società e dell’arte, nel quale inferire il lavoro senza bisogni diversi dai propri. La vicinanza al linguaggio di Plattner e Cremonini, si motiva con la condivisione di stimoli intellettuali ed estetici comuni, con una sostanziale difformità dal milieu artistico cittadino e nazionale; col pittore sudtirolese Anselmo spartisce gli insegnamenti di Carpi e Marini, con Cremonini l’amore per Parigi, il rapporto con la gallerista Catherine Viviano, e la scoperta di Panarea sul finire degli anni Cinquanta.
La fisionomia che assumono i lavori di Anselmo dal licenziamento accademico (1948), fino all’approdo nel Mezzogiorno d’Italia, avvenuto nel 1956 si conforma intorno ad istanti di normalità, la madre col figlio, l’animale domestico, la donna, il bambino, secondo un parametro che esige il pretesto del quotidiano, senza mitizzazione, piuttosto una dose di ironia. Le sculture sono di una plasticità tesa, tirata fino quasi al parossismo, che però tarda perché poco prima ciò avvenga comincia il rilassamento: ossia è giunto il tempo di cambiare, di lasciare l’approdo quasi raggiunto. Si tratta di una costante metodologica di Anselmo, che non si aggrappa mai ad un appiglio certo, anzi modifica la concezione del lavoro principiando sempre da un nuovo inizio. Addolcendosi, le sculture lasciano l’apnea esistenziale in cui sono calate, tornano a respirare, fino a perdere ogni insistenza innaturale dovuta al fatto stesso di voler riprodurre qualcosa che inevitabilmente non può essere copiato, ma solo interpretato.
L’arrivo a Panarea, tanto per Cremonini che per Anselmo risulta un evento eclatante e foriero di nuovi stimoli: entrambi vi scoprono la roccia. Mentre il pittore si lascia ammaliare dal chiarore della luce e comincia la tematica delle pietre, lo scultore abbandona i gessi e le dichiarazioni figurative per accogliere la spontaneità dei porfidi e delle pietre laviche, collezionate come ready-made e sbozzate al minimo per trafugare il senso immaginifico di un soggetto già pienamente custodito dall’originale – in quel sogno michelangiolesco di evincere ciò che già esiste in nuce nel blocco. Il nuovo metodo (1956-1958) è inconciliabile rispetto ai trascorsi, e distrugge la nitidezza delle figure che popolavano antecedentemente l’immaginario dell’artista. Tale utile rinuncia serve ad entrare nella materia, non più come artefice solitario di una forma inventata o imitata, bensì come co-artefice della natura stessa. In queste opere l’autore afferma un dato nuovo, ossia che la conoscenza può circoscriversi, realizzarsi, per mezzo dell’istinto (nel ritrovare la forma originale) e nell’esperienza del fare (che fa emergere il soggetto ripulendo le incrostazioni che ancora lo ingabbiano). Un antico motto zen recita: "(quando io) siedo quietamente, non faccio nulla. La primavera giunge e l'erba cresce da sé", e in effetti Anselmo lascia che la pietra parli e racconti le sue storie, le sue mitologie. Non uso a caso questo ultimo termine poiché, il periodo speso nel Sud, ed in particolare l’approdo sulle sponde siciliane con la discoperta della classicità, conduce Anselmo ad una nuova fase operativa nonché ad una nuova modellazione (1958).
Gli idoli antichi riaffiorano dal magma interiore del maestro, e non soltanto come forme ancestrali o archetipali che sfuggono alla classificazione dell’oggi, ma come segni o fenomeni di una civiltà dell’intimo che diviene realtà, verità. In questa occasione il modellato acquista forme più morbide, matriarcali, e il corpo scultoreo contiene lo spazio vuoto, che diventa metafora compositiva. Una terracotta del 1959, un vaso dalla cui pelle emerge il segno sintetico di un viso, descrive perfettamente il bilancio di vuoti e pieni messi in campo in tali occasioni, e lascia che esterno/interno si assommino nell’unicum creativo. Fa-tsang (643-712), un filosofo buddista del settimo secolo, intuiva l’universo come una rete di gioielli, ognuno dei quali contenente il riflesso degli altri all’infinito, percependo la contemporaneità delle compenetrazioni. Anselmo, nel lavoro dedicato agli idoli, partito senza dubbio dallo studio e dalla riflessione dell’età classica, abbraccia (sfiora) col tempo una filosofia più orientale in cui è difficile scovare la netta divisione fra stati opposti ascoltati nell’istante della loro eternità. Pieni e vuoti si completano, e le sculture di fine anni Cinquanta iniziano ad assumere forme sempre più larghe: una fisionomia che perde i connotati realistici in virtù della stilizzazione. I Budda, gli idoli che si allargano e divampano, sono tuttavia il preludio a una nuova stagione, quella degli anni Sessanta in cui la figura riduce all'essenziale, contrae e s’allunga a dismisura, pur senza lambire campi dell’astrazione alla Constantin Brancuşi (1876-1957), Jean Arp (1886-1966) oppure Alberto Viani (1906-1989).
Ancora una volta ripropongo la metodica del respiro come metafora del processo cui lo scultore sottopone i propri pezzi scultorei; egli non sclerotizza l’idea, piuttosto continua ad espanderla e ritrarla, insieme alle forme: tutto parte e torna allo stesso punto, ma non in senso circolare chiuso, bensì a spirale, in un vortice verso l’alto. L’istruttore di Tai Chi e scrittore Al Chung-Liang Huang, nel riportare un’antica parabola mandarina, racconta di come i due più veloci cavalli del regno partirono da Oriente per lasciarsi il sole alle spalle volendo guadagnare l’Occidente: presto però si trovarono di fronte a ciò che desideravano perdere; egli traduce l’espressione unitaria in lingua cinese "Oriente-Occidente" in "una cosa", "un qualche cosa" – e forse "niente" del tutto. Lo stesso percorso è battuto anche da Anselmo, che pur nell’apparente perdita di uno stile, lo riguadagna inalterato alla conclusione del viaggio, vorticando.
Ciò che attua negli anni Sessanta, agli inizi del decennio e fino al 1965, è una sintesi dell’uomo e dell’universo insieme: una grande Testa d’uomo ne definisce perfettamente l’intento, nel suo possente e antico prospetto. È il parlare di ciò che capitando dentro succede anche fuori. Non a caso, l’impegno assunto per la realizzazione del grande ciclo sul massacro degli armeni ad opera dei turchi, non può che cominciare dal riepilogo emotivo raggiunto. La contrazione cui è soggetta l’opera plastica di Anselmo si ferma dunque di fronte al bisogno-dovere di una nuova deflagrazione. E ancora il metodo del respiro potrebbe spiegare la necessità del riavvio. La rinuncia della scultura, in ultimo, non è che la chiara urgenza di continuare ad esplorare la forma senza forma tridimensionale. Col Massacro Anselmo entra nella dinamica della tragedia e della (in)umanità, (in)civiltà. L’orrore che la pittura intende aggredire non ha una forma tangibile, come intangibile è la violenza ideale. Ciò la scultura degli anni Sessanta lascia, un filo spietato e impalpabile, diventa in pittura manifesto poetico.
Per questo non scrivo o lo faccio mal volentieri, perché per scrivere devi sperare che qualcuno ascolti. E non ne vale la pena
Articolo pubblicato il 2 novembre 2005
|