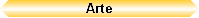
|
|
|
Alessandro Papetti. L’ombra indaco dell’attesa Di Flavio Arensi "Il blu esprime la verità" Si contano situazioni ambientali che non meritano il fastidio umano. Le ombre lunghe dell’attesa specchiano nel blu intenso dell’opera di Alessandro Papetti, quasi aspettassero presto o tardi l’ingresso: rimanendo però sospese. Si potrebbe divenire contemplatori di nuvole, o viandanti del cielo, per dimenticare le umane vicende, le storie senza ritorno - sentieri battuti per disperazione; poi, di tanto in tanto, scoprire che il lampo della tempesta di Giorgione è invece uno squarcio di sereno; dunque ritrovare la luce del sole. E nell’indaco terso della bella stagione: immergersi; come i corpi sciolti di ricordi d’azzurro in questi dipinti. Ricordo, ecco, io ricordo alcuni versi di Giovanni Pascoli, e davanti alle tele recito, sottovoce, come una lunga preghiera di consolazione: "Il sogno è l'infinita ombra del vero". Però ribalto all’indietro ogni pretesa di spiegare la vita presente, la carne che presto tardi dovrà marcire e le congetture con lei, dilaniando la cultura e le esperienze storiche, per ridarci la libertà d’essere vacui: recito meditando e poi inverto il concetto per acquistare affinità diverse, una verità limitrofa: "il vero è l’infinita ombra del sogno". Che sogno, che verità ci spettano? ciascuno i propri incubi e illusioni. Così Papetti dilata l’ombra dei volumi, la rende essa stessa materia di relazione; senza tuttavia pretendere di stringere il mondo reale, semmai intenderlo, anzi meglio ancora incalzarlo, accelerando il turbinio dei pensieri che intorno si agglomerano, rimorchiando sguardo e cervello. Capita quasi di essere trascinati al centro della tela, fra gli occhi dei personaggi ritratti, oppure nelle acque, o fino al termine della chiglia, comunque spinti dall’energia che frange in linee veloci, come le stelle quando prendono a girare nell’iride rapito del derviscio in comunione con Dio: vortici anziché punti. Papetti si pone di fronte all’oggetto senza la pretesa di un giudizio, né intende svelarne storie d’altronde misteriose, cerca viceversa un luogo d’incontro sul quale fermare lo studio (magari per un baleno, non certo oltre), quindi su di esso ritornare e ripartire migliaia di volte, costruendo traiettorie nuove e approdi diversi. Vi è un momento di pausa, l’attimo che giunge di sfuggita e talvolta neppure inteso, in cui finalmente i soggetti si lasciano catturare con la volontà di essere scorti: non afferrati; perciò, in questi quadri, il riposo s’indovina più che ravvisa: frenetico come il torrente che non necessità stasi di riflessione. La vita, d’altronde, quali spazi meditativi concede ai ritmi convulsi dell’Occidente? Il tempo non perdona e dimentica, procede ineluttabile al domani, che diventa immediato oggi, e già ieri. Fra un trascorso e l’altro qualcuno invecchia, altri crepano e nascono. I quadri di Papetti si inseriscono negli interstizi minimi del cronometro, colgono l’atmosfera, il delirio, cercano di costruire un rapporto che non sia soltanto sfuggevole comparsata, magari ammirazione; vogliono invece asserire uno scorcio di vita, l’intervallo che separa i secondi degli orologi, silenzioso e partecipe, partecipe e sconosciuto. Il cilestre cenerino scaglia come saette, o frustate, che dal basso salgono all’alto rastremando con la promessa di raggiungere il sommo del cielo; Papetti tende a costruire una struttura innalzata, riesce a far confluire gli innumerevoli segnali pittorici verso la dimensione esterna dell’opera, proprio perché il racconto non svolga soltanto sul piano del quadro, ma fuoriesca direttamente a contatto con la realtà dell’osservatore, sempre che ancora si voglia fingere di distinguere ciò che capita ai sensi dall’oscuro universo della mente, la vita dal sogno. Non trattengono questi scorci una verità maggiore di quella quotidiana, monotona e banale delle umane traversie? L’artista scruta fra le cose smascherandole, aprendo le porte della percezione per scovare il senso che oltrepassa l’immagine. I corpi indugiano imprigionati da una pioggia corrusca di colori, di materia che non cerca mai via di scampo, mentre condivide una sorte implacabile cascata addosso a uomini o situazioni, stanze vuote o grandi dimore, fino ai desolati ambienti industriali. Il pretesto del dipingere trasforma qualsiasi episodio in dialogo serrato, non vi è un resoconto soltanto, bensì innumerevoli voci che redigono le loro trame senza cura degli astanti; il vociare allestisce una monumentalità stupefatta in cui i protagonisti s’ergono come il capocomico sulla ribalta, e lì sopra egli inscena la sua interpretazione, talvolta un soliloquio disattento delle esigenze pubbliche, altre volte un commento delicato ai fatti della cronaca civile. È tuttavia nel vuoto, nella camera solitaria che Papetti espelle il disagio maggiore, quasi trovasse nei delicati decori o nell’arredamento sobrio delle moderne stanze, il suo esatto contrappunto, perché la città, cioè la grande casa degli esseri viventi, egli la evita, se non citandola dall’interno, come il medico che scende fino al centro delle viscere per analizzare il paziente. Ci sono, in alcune occasioni, grandi finestre che si aprono sull’esterno, e questo esterno consta di grandi cantieri navali, aree disabitate, alti forni o depositi industriali, ma anche della pelle tesa e suadente del corpo, il tono livido di alcuni passaggi subito raddolciti dal chiarore di certi grigi spezzati. Addosso a quelle pelli scivola il paesaggio che stanzia al di fuori dei palazzi, poiché i seni, le giunture delle costole, le ginocchia inarcate, o semplicemente la magrezza flebile della gioventù, sono la migliore beatificazione della natura, il suo dispiegamento più sincero. Scende la notte stellata nei pigmenti dei suoi blu deliranti, strappati in frammenti di filatura, opposti alla compatta temperie intensa dei notturni di un poeta come Rubaldo Merello, in quella sua Liguria ansante e celebrale. Negli olî di Papetti il torace si abbassa e il respiro diviene flebile, anzi trattiene un lungo sospiro. La tinta sfugge e non raggruma, quasi evapora boldinianamente, e sfilaccia come i dialetti testoriani in nuovi motivi. Eppure, pare quasi le ombre azzurre dei due pittori si tocchino, nell’affanno di trovare pace. Appunto più un affanno che una effettiva conquista, ma così è la ventura comune: cercare senza giungere alla meta, se non in punto di morte. Attesa. I dipinti hanno la fortuna di poter aspettare il futuro. Semplicemente fermi. Aspettano ancora i mari di Merello, aspettano i piroscafi in costruzione di Papetti, mentre il tempo intorno a loro sfiorisce e tramonta, come l’ultimo verso di una poesia che chiude e lascia un sipario d’infinito. Riposano, almeno, con le ombre mescolate alle luci, nel fremito della descrittività di Papetti, dove il caos ordina la sua leggenda e diventa continua recitazione di gesta. Flavio Arensi Articolo pubblicato il 22 febbraio 2005 |