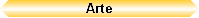
|
|
|
La dumka di Zoran Music di Flavio Arensi ad Oreste, con gratitudine Music a Dachau c’è stato un’intera stagione (sette mesi fra il 1944 e l’anno successivo): quell’infernale che lo ha stigmatizzato, e non per un tatuaggio offensivo, un achtung militare, o il fucile spianato con boria da un qualsiasi soldato, quanto per l’assillo irrinunciabile di condividere una sciagura umana. Con che coraggio io racconto un dolore altrui? I testimoni se ne stanno andando nell’oblio della storia, permangono i memoriali e le cronache dei libri di testo, di un’interminabile inventario di nomi: fantasmi che un tempo ebbero il sorriso. La memoria non basta a preservare dalla follia. Music non ci lascia dimenticare, ma impetra uno sguardo caritatevole e il silenzio della vergogna. Egli trattiene nei cromosomi la cultura liminale di Gorizia, benché filtrata dal crogiuolo mitteleuropeo della sua formazione. La parola dumka, dal verbo dumati appartiene a tutti i ceppi linguistici slavi, ma è anche una ballata elegiaca che ricorda le gesta dei cosacchi alla conquista della libertà, e della pace. Il musicista Antonin Dvŏrák ne intendeva una struttura musicale malinconica, inframmezzata a sezioni serene. Tutto scorre privo di pause, passa, si risolve, rinasce. Ugualmente Music compone da sempre le sue melodie visive nella costante proposizione di uno medesimo argomento drammatico e disilluso, con intermezzi distesi: sfiduciato l’uomo, ne cerca il nesso, ma coll’orrore scandito dagli occhi, quell’orrore che spunta nella certezza devastante del ciclo dedicato ai campi di sterminio nazista: Non siamo gli ultimi. Si affacceranno sul mondo altri tiranni, altri osceni delatori del male; poiché serve una scintilla di ferocia e una pletora d’ignavi per trasformare in lacerto il ghigno della nostra esistenza. Nel 1945, una volta riposti i residui della vicenda nazista, Music giunge a Venezia per cominciare un’intensa nuova fase lavorativa. L’eredità del lager ripone in un rotolo di carta qualche decina di disegni, fogli nascosti per timore, e sporchi dell’atrocità di Dachau. Questi primi abbozzi di sfacelo smettono per un ventennio di urlare, caduti nel sonno della ragione, pur con le loro piaghe scoperte. Inizia nel frattempo a dipingere i volti delle persone amate, la moglie Ida, s’autoritrae, per scovare fra le incertezze della Guerra un appiglio. Piano piano il proprio volto, i volti degli altri, si allargano, divengono paesaggi maculati, dolci e sensuali orizzonti collinari, pervasi di un eros strisciante ai confini del dolore, della morte che viene casta e pura come le vestali, sono gli scorci dalmati e senesi. Negli anni Settanta il credito che la devastazione ferale della shoah ha capitalizzato a suo discapito, torna a marchiare l’epidermide pittorica del maestro, e deflagra in una serie intensa di figure fantasmagoriche, dipinte nei colori spenti della sofferenza, stilate in parchi toni fangosi; spesso Music disegna le mani delle persone simili a uncini, perché afferrino l’aria, e con essa il denso nulla del loro intorno; Insieme ai dipinti stampa numerose incisioni: fogli acri, aguzzi, più brutali degli olî brumosi e sfumati. In queste acqueforti non si può sfuggire allo squarcio, al bulino che incide la lastra, penetrata come da un bisturi, e di ciò s’infetta col nero pecioso dell’inchiostro che tatuava i reclusi sagomando i resti di un addio, involontario, obbligatorio come quello che proffersero al mondo i deportati. Addio; non pietà dei loro aguzzini. Addio alla miseria della loro vita. Nel 1974, i testi di René De Solier accompagnano una cartella di sette litografie, con tiratura limitata a 130 esemplari (qui integralmente in mostra, insieme ad uno dei disegni creati per l’occasione): Cadastre de cadavres nebulizza il lutto per renderlo etereo, usufruendo della polverosa filigrana litografica col suo segno sbavato e grave. Contemporaneamente a Noi non siamo gli ultimi, Music appronta anche alcune tele a "Motivo vegetale", in cui i tralci, le radici e i rami si attorcigliano come braccia, gambe, addomi sgonfiati. Si tratta dell’identico motto ispirante, dell’identica dolenza da amalgamare alle paste pittoriche, e ai rimandi della memoria. Quindi, gli odori delle capanne, e le grida dei campi, dileguano nuovamente. La parentesi si richiude ancora una volta con una serie di autoritratti, e di nuovo i volti servono a cancellare le storie, anzi le nascondono nel fondo del cranio, dietro alle pupille allampanate per la carestia di pietà. Nel 2001, benché novantenne, egli propone una serie allucinata di autoritratti; allucinati d’ombra, abbagliati dall’oscurità che intorno si solleva, e forse altresì nell’intimo. È come se ci fosse nebbia in casa, e la scorgesse lui solo, aspirandola, trattenendola addosso. Questi disegni mantengono inalterata la forza dei cadaveri, sono essi stessi salme che si accartocciano come la foglia secca. Non vi è distinzione fra autore ed esperienza passata. Non distanza fra soggetto e fenomeno, fra sguardo e catastrofe. In ebraico il termine "catastrofe" si traduce shoah, il vocabolo scelto a sintesi del sacrificio ebraico, ma dovrebbe dirsi dell’intera umanità, cui Hitler sottopose la congerie terrena. Il suo trilittero originale risulta omofono a quello che definisce la parola italiana "vanità" (sheà), l’invano; sinonimo a sua volta del termine havèl, denotativo del vuoto, lo sperpero, e che ha suscitato a Kohèlet (Ecclesiaste) quella che Erri De Luca chiama "un’angoscia profana". D’altronde, quando Girolamo tradusse la Torah, la Bibbia ebraica, nella sua celebre Vulgata, trasformò havèl havelim in vanitas vanitatum, vanità delle vanità. Havèl corrisponde anche all’etimologia di Abele (cambiano in realtà le vocali, mentre la radice consonantica rimane identica), il figlio di Adamo ed Eva, il cui sangue fu versato ingiustamente dal fratello Caino: sprecato, trasformato appunto in evanescenza, offerto vanamente quale olocausto. Così, anche i martiri dei campi sono carne e sangue sprecati sull’altare del vano agire umano, sono "abeli" senza gloria. La catastrofe è dunque uno sperpero di corpi, di anime, massacrate in virtù di un progetto distorto e micidiale, cieco e ferino nel contraddire il futuro. Quale domani attende il deportato di Dachau, il prigioniero dei gulag e della Siberia, il recluso di Guantanamo, dei nuovi campi in cui si disperde la parte dignitosa dell’essere vivente? Gli autoritratti di Music pretendono un futuro, per converso negato ai suoi compagni di sventura nazista, a quelli che - diversamente da lui - conobbero la mano del boia, o il gas venefico della follia omicida. Ebbene, poter vantare un avvenire, un giorno successivo a quello vissuto, ne ricorda all’uomo la condizione emancipata; la libertà profonda cui partecipa attimo dopo attimo, costantemente. L’insegna che campeggiava sopra il cancello di Auschwitz recitava il mefistofelico motto "Arbeit Macht Frei" (Il lavoro rende liberi). Fu posta lì dal maggiore Rudolph Höss, comandante del campo, non con intento beffardo, e nemmeno come falsa promessa rivolta a coloro che, lavorando fino all’esaurimento, sarebbero stati infine liberati; trattasi al contrario di una dichiarazione pseudo-mistica per la quale il sacrificio di sé, sotto forma d’infinita fatica, arrecherebbe intrinseca libertà spirituale. Ad Auschwitz s’offriva un futuro di morte, che a Dachau viceversa si taceva, lasciando all’incertezza il nero della paura e del terrore che arreca l’ignoranza circa il proprio destino. Non vi era libertà di pensare il futuro. Non la minima avvisaglia di una decisione finale. Si stava sospesi in "apatica attesa". In Music, manca la disperazione; vi è già il verdetto della condanna, la sconfitta, oppure la serenità dello scampato pericolo, o la calma degli ignari. Silenzio e rovina convivono in senso allotropico, cioè coesistono due diversi esiti di uno stesso significante; non vi è differenza fra morte e vita, poiché ne coincidono gli estremi, nel circolo vorticoso e costante dell’esistenza. In tale cerchio chiuso, si alternano momenti a momenti, bestialità a laudi, lai a bestemmie. Si tratta di una composizione intensa, ribadita allo spasimo, con continuità: chi si ferma è finito. Music ha inscenato, in oltre mezzo secolo, la sua melodia straordinaria, la sua dumka, proprio come quella in cui Dvŏrák ha esibito tutti gli stati d’animo, però con particolare invito alla meditazione sulla morte (in verità una meditazione sulla vita), sicché, trascrivendo i ricordi di Dachau, il maestro dimostra come proprio la vita prosegua a dispetto del dramma: nonostante l’incubo della notte, il mattino porta la quiete. La sua testimonianza s’incastona nella pittura, che diviene il vestigio della nostra presunta (o desiderata) eternità. Noi, non siamo gli ultimi. Articolo inserito il 28 aprile 2004 |