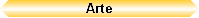
|
|
|
Partecipazione israeliana alla cinquantesima Biennale di Venezia Di Raffaele Bedarida È troppo facile attaccare la Biennale di Venezia. Tutte le Biennali, come ogni ampia rassegna internazionale, attirano inevitabilmente critiche e suscitano polemiche dal momento che le aspettative da parte del pubblico sono alte, e difficile è il compito di chi deve cogliere, nel vivo del suo divenire, una situazione artistica mondiale di grande complessità. Ciò che però delude maggiormente nell’ultima Biennale, è una compiaciuta sciatteria negli allestimenti e un qualunquismo inquietante nel taglio critico. Ne risulta un panorama mediocre e noioso, in cui la presenza di artisti israeliani gioca un ruolo straordinario. Non erano mai stati così tanti e il loro livello qualitativo è sopra la media; naturalmente con qualche eccezione. Ma anche sulle ragioni della numerosa presenza degli israeliani sorge qualche dubbio. Ho infatti la sensazione che siano stati chiamati con una certa leggerezza, la stessa che si respira nella sezione dell’Arsenale intitolata Rappresentazioni arabe contemporanee: è come se avere artisti israeliani o arabi desse la garanzia illusoria di un impegno, in modo da legittimare un’esposizione di fatto disimpegnata e incosciente. In realtà non basta inserire una sezione dedicata al mondo arabo o condire abbondantemente l’esposizione di artisti israeliani, quando manca l’assunzione da parte dei curatori di una posizione problematica e seriamente meditata: ne consegue l’ennesima conferma di un diffuso clima di superficialità. Generalmente il percorso, il taglio critico di una mostra è uno strumento che chi la organizza offre al visitatore; è una proposta del curatore per la comprensione del senso stesso dell’esposizione. Il direttore di questa Biennale, Bonami, ha risolto il problema con lo stratagemma de La dittatura dello spettatore (secondo titolo di questa Biennale), ovvero la proposta di una fruizione sul modello dello zapping televisivo: nel caos brulicante di un’offerta incontrollata, il consumatore/spettatore si crea il proprio percorso ed opera le proprie scelte. Si tratta di un espediente per non assumersi la responsabilità di una scelta e il risultato è una mostra in cui non c’è un taglio critico. Con questo presupposto mi sento quindi autorizzato ad intraprendere un altrimenti arbitrario percorso tra alcuni degli artisti israeliani dislocati nei diversi spazi espositivi veneziani, e ad ignorare, quasi, il contesto vago e poco comprensibile che li circonda: mi limiterò semplicemente a prenderli in considerazione separatamente, in base alla sezione della mostra in cui sono collocati1.
Carmit Gil Estremamente efficace è il sobrio minimalismo dei tubi rossi che, isolati, ricordano i giochi nei parchi pubblici dove i bambini si arrampicano; sono forme che ispirano fiducia, alle quali, nei parchi come in autobus, ci si aggrappa per istinto primordiale, quasi scimmiesco. Il riferimento agli attentati terroristici che quotidianamente terrorizzano la popolazione d’Israele e ogni altra persona sensibile, è qui un fatto oggettivo, vicino, silenzioso: non c’è retorica né patetica emotività, niente di gridato né facili giudizi; è l’immagine essenziale, profonda e agghiacciante di una condizione che sembrerebbe impossibile comunicare a chi non la vive ogni giorno. Significativa, ma più da un punto di vista storico-documentaristico che per reale forza di ricerca artistica, è la serie di ritratti dei ministri del parlamento palestinese che Efrath Shvily iniziò a scattare nel maggio 2000 con l’intento di renderli familiari agli israeliani, di far superare un’aprioristica diffidenza nei loro confronti. Il lavoro fu interrotto dallo scoppio della seconda Intifada. Presentarli oggi in un ambito di confronto internazionale è un atto denso di significato, dettato da una vera esigenza comunicativa: dar voce ai tentativi di costruzione dei presupposti necessari ad una convivenza. Questi tentativi non trovano spazio sui media internazionali e momenti come la Biennale divengono opportunità insostituibili al fine di recuperare la reale complessità di una situazione appiattita e distorta dalla cattiva informazione. I sei schermi della videoinstallazione Map (2003) realizzata da Amit Goren, risultano di difficile lettura. Si presenta, in questo caso il problema, frequente in rassegne così estese, del tempo di fruizione di ogni opera: sei video di 8 minuti l’uno, pretendono per sé troppo tempo rispetto a quello che è "giusto" (è un fatto etico!) dedicare ad ogni opera. Vi si intrecciano immagini della cronaca, fatti personali, e di vita quotidiana dei campi palestinesi, in una complessa compresenza di livelli di vissuto che s’intrecciano e confluiscono nell’esperienza del singolo individuo.
Nahum Tevet Alla frontale fotogenia del mobile componibile, pensato anche per ben comparire sui cataloghi di vendita, egli oppone un sistema di pieni e vuoti complesso, del quale risulta impossibile stabilire un punto di vista privilegiato e difficile trarre una buona immagine fotografica.
Michal Rovner La Rovner in questa occasione rinnova con intelligenza una ricerca elaborata e sviluppata nel corso degli ultimi anni fino ai risultati spettacolari della grande mostra al Whitney Museum di New York e della recente installazione romana all’ex mattatoio di Testaccio: uomini minuscoli si agitano, si muovono, in fila o a schiere, in gruppi compatti o in un caotico brulicare. È uno strumento versatile ormai acquisito nel linguaggio dell’artista, utilizzato con maturità e piegato alle proprie esigenze con estrema precisione. Soltanto nelle diverse tappe del breve percorso nel padiglione, infatti, questo stesso elemento linguistico è usato in una varietà notevole. L’immagine d’origine è una fotografia in bianco e nero, sulla quale l’artista interviene, come vedremo meglio successivamente, eliminandone i dettagli e l’identità; le figure sono ridotte a poco più di sagome e lo sfondo, presente nei lavori della Rovner ancora fino ad un anno fa, dopo una progressiva semplificazione, si è dissolto in un bianco completo.
Michal Rovner Da una parte l’utilizzo rigoroso del bianco e nero inserisce l’opera della Rovner in un ambito operativo che si caratterizza per un approccio morale e impegnato al fare arte, in concreto confronto con la storia - con primo riferimento d’obbligo Guernica. In secondo luogo c’è un gusto grafico, si ricrea nel digitale il piacere della superficie candida della carta: i riferimenti, nelle sue opere, alla scrittura, alla pergamena, ai geroglifici, al foglio pentagrammato o carta da parati, rimandano continuamente alla dimensione della scrittura su carta. Questo inserisce la ricerca della Rovner in un utilizzo nuovo della specificità linguistica dell’immagine digitale - sia fotografica sia video – piuttosto rara in ambito propriamente artistico, ma in voga, anche se con altri scopi, nella grafica pubblicitaria: la diffusione dell’utilizzo della fotografia digitale nel grande pubblico, anche a soli fini turistici o domestici, ha fatto sì che la percezione dell’immagine fotomeccanica sia mutata. Infatti finora un’immagine fotografica, per quanto imprecisa, sfocata o poco leggibile, rimandava direttamente all’oggetto ritratto, ne era comunque l’impronta digitale, ne condivideva l’essenza, e rispondeva quindi ad un’esigenza umana: ne soddisfaceva l’appetito di verità, la necessità di mummificare il reale (Bazin). Oggi invece il pubblico ha completamente metabolizzato l’immagine modificata e addirittura la realtà virtuale: è venuta meno la corrispondenza essenziale tra l’oggetto ritratto e la sua riproduzione fotografica. Oggi l’immagine fotografica-digitale è immagine creata dall’uomo; è altro, è indipendente dalla sua fonte (se mai è esistita). Utilizzarla come elemento grafico, riuscire a scrivere con essa, prenderci velocemente appunti, significa cogliere la potenza aurorale, originaria di un nuovo strumento linguistico nella sua specificità. Anche ciò contribuisce all’intensità epica delle immagini della Rovner su cui torneremo. Sul muro esterno, Wall Text ci accoglie e ci introduce al padiglione. Gli uomini in miniatura sono stampati sull’intonaco in più file sovrapposte e compongono una vera e propria scritta (come indica il titolo stesso) fatta di segni incomprensibili. Mordechai Omer, (commissario e curatore del padiglione, nonché direttore del Tel Aviv Museum of Art) li assimila a geroglifici egiziani e ai manoscritti del Mar Morto. Purtroppo la cura nelle rifiniture delle opere all’interno non si riscontra all’esterno, dove il muro è scrostato e l’immagine di cui è supporto ne risulta in parte cancellata. Si tratta comunque di un’opera introduttiva, e bene svolge il ruolo di richiamo e di piccolo assaggio/anticipazione alla vera opera che è quella all’interno. Il movimento degli omini, ridotti a poco più di sagome nere, che si agitano, piccoli e sparpagliati in un grande bianco mentale, creano una spazialità piuttosto vicina alla serie dei Pretini scattata da Mario Giacomelli nei primi anni Sessanta: nelle immagini in movimento della Rovner, però, lo spazio rarefatto di Giacomelli, muta in un continuo pulsare e variare di densità. Il nucleo del progetto e principale novità nella ricerca dell’artista, è Data Zone. In un ambiente da laboratorio, su tavoli bianchi, sono inserite venticinque tonde piastrine di coltura. Dentro le capsule i soliti piccoli uomini, visti dall’alto, si muovono. Ogni piastrina ha caratteristiche diverse: in una piccole file di uomini procedono in percorsi sinuosi e s’intrecciano tra loro come nelle immagini microscopiche dei batteri; in un’altra è un caotico brulicare e un continuo mutamento dei punti di addensamento e di rarefazione; altrove piccole file si agitano nelle loro componenti rimanendo ferme sul posto. Per molti aspetti, come l’utilizzo dei tavoli trasparenti e delle piccole immagini grafiche in bacheca da gustare da vicino, chinandosi, rendono quest’opera vicina all’installazione di Mattew Barney alla stessa Biennale (Padiglione Italia): c’è un comune riferimento al mondo dell’osservazione e della raccolta scientifica, più di tipo magico-alchemico, di derivazione dalle wunderkammer in Barney, più analitico e attinente all’immaginario attuale della biotecnologia nella Rovner; all’organica e strabordante visionarietà del primo, si oppone nell’opera della Nostra una non meno inquietante oggettività raggiunta per sottrazione. La veste rigorosamente scientifica dà autorità all’immagine della Rovner, che diviene fatto oggettivo, depurato di ogni emotività. C’è qui un molteplice livello di drammaticità: l’ostentato distacco, la pretesa di oggettività è in realtà una ricerca altrettanto affannosa (anche se raffinatissima) dell’artista, che è parte di quell’agitarsi dei piccoli uomini sotto-vetro. Anche lo spettatore che si aggira per i tavoli e si piega a guardare nelle capsule di Petri, ha una prima sensazione di controllo e superiorità: sorride, quasi, osservando questi esseri minuscoli muoversi freneticamente; quando poi si rende conto che quell’immagine lo cattura più di una normale piastrina di laboratorio, capisce di essere parte dello stesso affanno, che in quel medesimo istante si sta manifestando nella sua sete di capire, trovare, cogliere qualcosa in quell’immagine. Il pubblico partecipa inconsapevolmente ad una farsa, e solo alla fine, quando se ne rende conto, ogni sua azione precedente gli si ribalta addosso investita di nuovo senso. Molti hanno parlato a proposito di quest’opera, di bio-tecnologia: sicuramente c’è anche la bio-tecnologia, ma non è che un aspetto, forse estremo, di questa ben più ampia, frenetica ricerca. La veste da laboratorio va piuttosto intesa come ricostruzione di un contesto da indagine scientifica, che studia dall’alto un fenomeno; fa parte della stessa farsesca messinscena che rende gli uomini simili ad aminoacidi. L’immaginario che ruota intorno agli esperimenti bio-tecnologici è utilizzato come strumento linguistico. A conclusione del percorso espositivo, la grande installazione Time Left. È molto simile a quella già realizzata per la mostra del Whitney. In una sala quadrata e buia, le quattro pareti sono tappezzate di immagini proiettate: gli omini questa volta sono ripresi frontalmente, uno accanto all’altro su un fondo bianco, creando strisce nere orizzontali. Fermi sul posto si agitano muovendo le braccia, le gambe, la testa e il corpo. La precisione con cui le proiezioni coprono le quattro pareti dalla base al soffitto e l’esattezza con cui si congiungono agli angoli in una perfetta continuità, danno la sensazione di una carta da parati dai motivi decorativi mobili, o meglio di geroglifici parietali in movimento. Mordechai Omer ricorda che <<Michal Rovner ha eseguito le riprese per la sua opera in Russia, Romania e Israele. Per gli spettatori il luogo dov’è stato ripreso il video non è né evidente né importante al fine di leggere l’opera, ma comunque, i luoghi sono stati accuratamente selezionati da Rovner come punto di partenza per creare la sua ambientazione>>. Questo le permette di distinguere chiaramente il proprio rapporto con l’immagine in due diversi momenti di elaborazione che corrispondono a due passi fondamentali di un processo conoscitivo: la prima fase consiste nel cogliere un’immagine carica di memoria storica e personale, desunta da luoghi impregnati di significato individuale e collettivo; l’intervento sull’immagine e la stampa, avvengono successivamente e altrove (a New York). In questa seconda fase dal soggetto si sottrae specificità temporale e geografica. Il luogo o la persona ritratta in origine diviene così topos di riferimento, luogo di riflessione su una condizione. Si crea un’immagine/racconto di tipo epico. Continua Mordechai Omer, <<Come artista israeliana che vive in America e crea la sua arte da immagini riprese in Russia in Israele e in altre parti del mondo, Rovner attraversa le frontiere nazionali e crea ciò che ella chiama "nuove realtà" da nazioni e situazioni politicamente esplosive>>. Sono rari gli artisti che riescono a parlare al di fuori di episodi circostanziati con la forza e concretezza di un fatto urgente: come dice Omer <<si tratta di un testo sull’umanità>>, e questo avviene senza che ci sia alcuna facile caduta nel retorico o nel banale, in una delle opere più intense viste negli ultimi anni. 1 Una breve legenda sulla suddivisione di questa Biennale: vi sono luoghi espositivi nazionali (i padiglioni) in cui ogni paese propone delle opere rappresentative scelte trai propri artisti in linea con il tema di base della Biennale (Sogni e conflitti/La dittatura dello spettatore); e luoghi internazionali che il direttore, coadiuvato da altri curatori, progetta scegliendo tra artisti di tutto il mondo. I luoghi espositivi sono principalmente due: i Giardini ospitano la maggior parte dei padiglioni nazionali, il grande Padiglione Italia dove è allestita la rassegna internazionale Ritardi e rivoluzioni, e uno spazio dedicato alla giovane arte italiana (The zone); e l’Arsenale, tutto adibito al confronto internazionale, si suddivide nelle sezioni, Clandestini, Smottamenti, Sistemi individuali, Zona d’urgenza, La struttura della crisi, Rappresentazioni arabe contemporanee, Il quotidiano alterato e Stazione utopia. Vi sono poi altri padiglioni nazionali sparsi per la città e la sezione Interludes (inserita in zone interstiziali della mostra e della città). Infine al museo Correr si trova la mostra Pittura-Painting che ripercorre la storia della pittura internazionale dal 1964 ad oggi attraverso le Biennali intercorse in questo lasso di tempo. Articolo inserito il 14 ottobre 2003 |