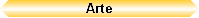
|
|
|
Giuseppe Ajmone. Verrà l’autunno Di Flavio Arensi "El otoño vendrá con caracolas, Talvolta, tremori impalpabili sfuggono e corrono sottopelle inabissando come il battere flebile delle morte stagioni. Giuseppe Ajmone realizza la lusinga della vibrante intesa fra la natura e i corpi femminei delle bagnanti, coi grandi fondoschiena che stabiliscono l’aura erotica di tanta sua pittura, e da lì, indietreggiando, questa aura diventa un palpito di colore e luce, uno scorcio di territorio. Lo spazio non esiste a priori; la materia dipinta segna il vuoto, rendendolo vivo, ansimante, carne e ossa, fiori e stratagemmi paesaggistici che dirompono come il tiepido calore dell’esistenza. Un tepore che presagisce il freddo invernale, lentamente stempera in poetica dell’attesa, pure di una speranza mancata. E intanto i pianti delle donne diluiscono la tensione di LLanto por Ignacio Sánchez Mejías, il quadro che nel 1945 segna la rottura col passato, avviando invece un diverso rapporto dialogico con le prospettive internazionali, filtrate comunque attraverso l’eleganza del pensiero autonomo e dell’esigenza esperienziale. Non manca ormai il sapore autunnale di addio, di chi arriva e sa di dover presto ripartire, tuttavia viene, e in questa sua venuta porta l’intenso trascorrere delle ore, delle età, che avvizziscono e restano comunque presenti. Nel LLanto il morto è come terra gravida da cui fioriscono le figure nude, ceri confusi, quelli mesti di Kostantinos Kavafis e delle sue nostalgie e dei suoi inganni, nell’ombra nera della lirica di Federico Garcia Lorca, in cui il sudore di campagna avvolge la rivoluzione: entrambi annebbiano, insieme al mare. Che strano trovare, quarantacinque anni dopo la sua realizzazione, un altro quadro, Raccolta di olive di José Ortega, e ripercorrere l’identica invenzione notturna, ma di quella notte che stanzia al sole perché propria della coscienza. Entrambi riferiscono l’allontanamento che giunge a sera, sia questa il tramonto di chiusura dei campi, o la nera signora che miete vite anziché grano. Qui, in queste scene tragiche di veglia al cadavere, Ajmone pone la grammatica racchiusa nel Manifesto del Realismo, e in quel Oltre Guernica che definisce una presa di posizione etica ancorché estetica, assaporando il senso convinto di una lezione assunta nondimeno superata per sfuggire le maglie della ripetitività. Mentre Ennio Morlotti si rifugia nel paesaggio, prima d’incontrare finalmente Imbersago, e Bruno Cassinari educa il colore alla nobiltà delle sue lacche, egli passeggia nell’introspezione delle nature morte essenziali come in Henri Matisse, però frementi di una pasta corrusca, sospirata centimetro per centimetro. Da qui dunque, lentamente, la superficie vibra di smottamenti che non sono materia, ma bagliori e suoni, fino ad avvampare nell’inedito Nudo del 1958, che si scalda e brucia come la selva boschiva in un Incendio di Renato Birolli. La lezione di Corrente riporta lo sguardo lontano dagli avamposti del Novecento, aprendo un pertugio verso Parigi, da dove poi si torna come di pellegrinaggio, quasi Ajmone compia la sua via francigena dirottando infine verso le terre di Spagna, entro cui trova lo stimolo letterario per proseguire il cammino d’immagini. Senza, infatti, approfondimento culturale egli non avrebbe potuto fondere la congerie gergale lombarda, in quel crepuscolo di intelligenze che fra le Alpi e il Po comunque continua a credere nella vitalità della pittura, a un linguaggio nuovo frammisto di fascinazioni europee, stillato da scansioni impressioniste e frangenti esistenziali. Il ritmo è quello dei grandi naturalisti, Jean-Baptiste-Camille Corot, l’inventiva di Gustave Courbet, eppure tradotto nella rapidità di fulmini e scorci celesti come negli artisti del Tamigi. Inoltre, la collaborazione con Einaudi e il circolo torinese lo pongono prepotentemente nel dibattito culturale del tempo, con le aperture all’America e alle grandi stagioni narrative del Dopoguerra. Letteratura e pittura francese si fondono in Ajmone come a penetrare d’ogni dove la materia per smuoverla da dentro, significando un monito che oltrepassa forma e spazio, tempo e verità. Esterno e interno si avvicendano in giochi dinamici nei quali il punto di vista prospettico dilegua in virtù di un racconto che stimola l’intenzione filosofica ed emotiva. Ajmone non manca di istruire, nella stagione degli anni Cinquanta, la disamina rigorosa della natura esistenziale della nostra umanità, menzionando ambienti nebbiosi, ma di quella nebbia pascoliana che censura la vista e opprime il cuore. Il fiato in questi quadri si ferma all’inizio del petto, ansando con l’agitazione di chi partecipa di un destino. Fin dalle sue prime esperienze, giungendo ai lavori accademici degli anni di Brera, e poi nelle prime nature morte che subito mutano in corpi o brandelli di figure, il pretesto del soggetto nasconde l’esigenza primaria del mestiere pittorico esercitato come chiosa del mondo, e aspirazione sociale. Nel primo caso è ovvio pensare a una parafrasi del veduto che vinca l’aporia di una realtà affatto legata al piano fisico, piuttosto tesa a coniugare per sintesi lo spirito, l’intelletto, le carni. Perciò, i soggetti recepiscono quasi da subito un’ampia valutazione sociologica che non comprende, come nella scelta del realismo politico guttusiano, la lotta di classe bensì la più attenta e lucida (vasta) denuncia del malessere comune. In quest’ottica Ajmone erige la propria etica del dipingere che, pur nella modifica dei toni, contempla costantemente la stessa armonia. Se variano dunque i soggetti, la loro strutturazione o destrutturazione, egli perpetua l’attitudine patologica a caricarsi delle ansie e dei rapimenti di norma caratterizzanti la quotidianità; non rinuncia alla compartecipazione totale dei mali e delle glorie di un’intera epoca, trasportandone i vizi ed esaltandone la virtù, pur sempre però nell’alveo inquieto della pittura di "tradizione", intesa non come convalida di uno stile reazionario, bensì nel costante ed esaltato nuovo asserto di temi senza tempo e senza padri che da Masolino osano fino ai giorni presenti. Le tematiche affrontate da Ajmone infatti riflettono l’universalità piena ed eccitata disposta all’interno di una lingua pittorica che trova continui stimoli a rigenerarsi. La pelle di Raffaello talvolta pare oltrepassare la possibilità umana di sussistenza. Oltrepassa il miracolo stesso che la pittura porta seco, vanificando ogni tentativo di rendere alla verità osservata la verità sentita nel cuore. La pelle batte sopra il fluire caldo del sangue. Ecco, quel piccolo sussulto che separa una pulsazione dalla successiva si racchiude nei transiti lirici di Ajmone, si arriccia come un sogno fra le palpebre chiuse del sonno, dilegua e ritorna come il verso dolce di una nenia. Sempre uguale. Cambiano le voci a ripetere la fiaba della buona notte, però la carezza permane intatta, mano dopo mano, secolo dopo secolo. Il pittore spegne lo stoppino della candela, non lascia che il tempo consumi il grasso della cera. Così Ajmone trasloca da un motivo all’altro - da una tematica alla seguente - la sua eleganza asciutta, la tristezza di certi sguardi compassionevoli e muti, le diciture di versi e libri ormai accatastati nella memoria. Le donne in pianto del Llanto ora sono alle sponde del fiume, ora divengono il paesaggio morbido dell’imbrunire, ora addiruttare Trajes de luces, un altro quadro imprescindibile. Ancora la luce, e i raggi che illuminano il pianeta e con esso tutte le creature. Vi è dunque una coscienza maggiore che tutto rischiara e abbrunisce, nel tremore candido che sottopelle distende l’autunno della nostra stagione mortale. L’autunno prima del gelo d’inverno. Flavio Arensi Articolo pubblicato il 22 febbraio 2005 |